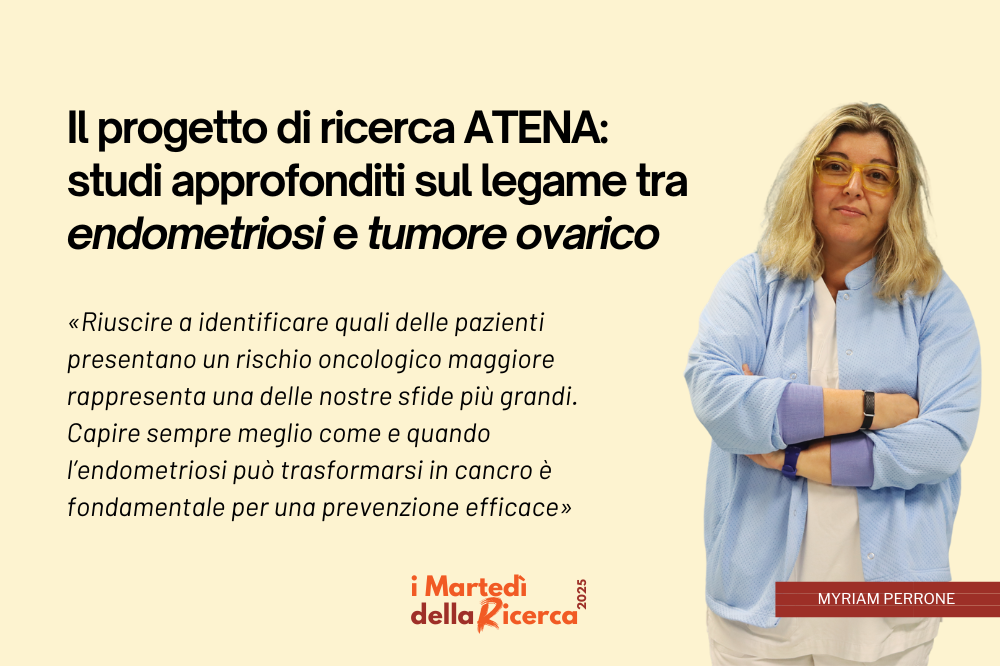Grazie al progetto di ricerca “ATENA”, finanziato dal Ministero della Salute, un team di ricerca del Policlinico di Sant’Orsola è riuscito non solo a identificare alcuni biomarcatori capaci di riconoscere l’endometriosi destinata a evolvere in carcinoma, ma anche ad individuare due diverse tipologie di carcinoma ovarico in presenza di endometriosi (correlato e incidentale) e a descrivere per la prima volta in modo sistematico le caratteristiche del mesonephric-like adenocarcinoma. I risultati stati pubblicati sulle riviste “Translational Oncology” e “International Journal of Gynecological Cancer”.
L’endometriosi come fattore di rischio di numerose patologie. L'endometriosi è una malattia cronica, dolorosa e invalidante che colpisce circa il 10% delle donne in età fertile. Comporta la crescita di un tessuto simile al rivestimento interno dell’utero (endometrio) anche al di fuori di quest’ultimo. Nonostante sia di natura benigna, questo tessuto presenta caratteristiche simili a quelle tumorali, in particolare la capacità di diffondersi e infiltrarsi in altri tessuti.
Ormai da tempo la comunità scientifica si interroga sul legame fra endometriosi e tumore ovarico e le evidenze raccolte mostrano come l’endometriosi rappresenti un fattore di rischio per diverse neoplasie, incluso il carcinoma ovarico. In base ad alcuni studi recenti, infatti, nelle donne affette da endometriosi il rischio di sviluppare un tumore ovarico è significativamente superiore rispetto alla popolazione generale.
Al tempo stesso, è importante sottolineare che avere l’endometriosi non porta necessariamente allo sviluppo di un carcinoma ovarico. Anzi: “L’insorgenza di un tumore ovarico in presenza di endometriosi resta comunque un evento raro: le donne affette da endometriosi presentano un incidenza di tumore ovarico tra lo 0.6% a l’1%, rispetto allo 0.1% della popolazione generale - chiarisce la prof.ssa Anna Myriam Perrone, specialista della Ginecologia Oncologica del Policlinico di Sant’Orsola IRCCS - Tuttavia, riuscire a identificare quali delle pazienti presentano un rischio oncologico maggiore rappresenta una delle nostre sfide più grandi. Capire sempre meglio come e quando l’endometriosi può trasformarsi in cancro è fondamentale per una prevenzione efficace”.
Il problema è che al momento non esistono metodi di screening efficaci per rilevare precocemente il carcinoma ovarico: l’unica opzione preventiva resta dunque l’asportazione chirurgica degli annessi (ovaia e salpingi). Nell’ambito del progetto “ATENA” (“Artificial inTelligence as tools for Early diagnosis and precision surgery in eNdometriosis-related ovArian cancer”), un team di ricerca del Policlinico di Sant’Orsola e dell’Università di Bologna ha quindi indagato a fondo il legame tra endometriosi e tumore ovarico. Giungendo a diversi risultati promettenti.
Endometriosi e due tipi di tumore ovarico: correlato e incidentale. Il primo risultato è stato pubblicato pochi mesi fa sulla rivista “International Journal of Gynecological Cancer”. Studiando i campioni prelevati da 87 donne con carcinoma ovarico associato ad endometriosi (a partire da una coorte totale di 170 donne operate per carcinoma ovarico), i ricercatori hanno osservato un’elevata eterogeneità: alcuni tumori contenevano aree di endometriosi benigna, borderline e carcinoma, mentre in 39 pazienti era presente esclusivamente endometriosi benigna, senza evidenza di trasformazione maligna.
L’analisi ha quindi permesso di identificare e studiare due sottotipi distinti di tumore ovarico in presenza di endometriosi: il tumore ovarico che deriva dalla trasformazione maligna dell’endometriosi e il tumore ovarico associato ad endometriosi benigna incidentale, priva di ruolo causale. “La scoperta che esistano due diverse tipologie di endometriosi, con comportamenti biologici distinti, potrebbe rivoluzionare il nostro approccio alla diagnosi e alla gestione clinica – continua Perrone – L'identificazione di questi sottogruppi apre infatti la strada a ulteriori ricerche sulle interazioni tra endometriosi e cancro ovarico, potenzialmente rivelando tipi distinti di tumore. Questo potrebbe portare a strategie di trattamento più personalizzate, soprattutto se combinato con altri fattori ambientali”.
MiRNA come biomarcatore di endometriosi che causa di tumore. Proprio in questa direzione si è mosso un secondo studio traslazionale, che si è focalizzato sulla possibilità di capire quando l’endometriosi costituisce un fattore causale del cancro ovarico. Lo studio – i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista “Translational Oncology”, ha infatti identificato alcuni marcatori associati sia alla forma benigna che a quella maligna della patologia: si tratta di microRNA (miRNA), piccole molecole di RNA non codificante presenti nei tessuti e nel sangue che intervengono nella regolazione di diversi processi cellulari, inclusi quelli tumorali.
I ricercatori hanno analizzato i campioni prelevati da 37 pazienti, alcune con tumore ovarico associato ad endometriosi e altre con endometriosi ovarica benigna, prelevando un campione di tessuto endometriale su cui è stato fatto il sequenziamento dei microRNA. Tramite rigorosi metodi statistici è stato possibile individuare alcuni microRNA altamente significativi nel distinguere le due forme di endometriosi. Lo stesso procedimento è stato ripetuto confrontando il microRNA di tessuto di endometriosi ovarica benigna e il tessuto del tumore ovarico associato ad endometriosi.
Il risultato? Sono stati identificati nove microRNA capaci di riconoscere con accuratezza pressoché assoluta (100%) l’endometriosi destinata ad evolvere in carcinoma ovarico. Altri quattro microRNA “sentinella” sembrano essere ottimi “segnali di trasformazione” - cioè marcatori che indicano quando un’endometriosi potrebbe evolvere verso il cancro - in quanto la loro concentrazione aumenta lungo l’intero continuum: endometriosi benigna, atipica, carcinoma borderline/maligno.
"Grazie all’analisi dei biomarcatori nei tumori in cui l’endometriosi evolve attraverso un processo multistep, dall’endometriosi benigna, all’endometriosi atipica, fino al tumore maligno o borderline, siamo riusciti a tracciare profili specifici – conclude la prof.ssa Perrone - Il prossimo passo sarà cercare questi marcatori direttamente nel sangue o nella saliva, per sviluppare test di diagnosi precoce”.
Prima descrizione sistematica di tumore ovarico Mesonephric-like adenocarcinoma (MLA). Sempre nell’ambito del progetto “ATENA”, infine, i ricercatori sono riusciti a individuare, tra i tumori ovarici che possono svilupparsi dalla trasformazione maligna dell’endometriosi, un sottotipo di tumore ovarico estremamente raro: il mesonephric-like adenocarcinoma (MLA).
Come lascia intendere il nome, il mesonephric-like adenocarcinoma (MLA) può imitare le caratteristiche microscopiche di tumori derivanti da residui embrionali chiamati dotti mesonefrici, i quali normalmente sarebbero destinati a scomparire durante lo sviluppo fetale. Durante il progetto di ricerca è stato possibile descrivere per la prima volta in modo sistematico le caratteristiche cliniche, ecografiche, patologiche e molecolari del mesonephric-like adenocarcinoma (MLA) confermandone il legame con focolai di endometriosi. Ne è stata inoltre confermata l’elevata aggressività. Anche i risultati di questo studio sono stati pubblicati sulla rivista “International Journal of Gynecological Cancer”.
Le prospettive future. Questi risultati aprono la strada a strumenti sempre più precisi per riconoscere l’endometriosi ad alto rischio oncologico e, magari in futuro, in modo sempre meno invasivo, con l’obiettivo di intervenire prima che la malattia evolva in forme maligne.
Il progetto ATENA è frutto dello sforzo collettivo di tutto il team di ricerca guidato dalla prof.ssa Anna Myriam Perrone, dell’unità operativa di Ginecologia Oncologica, e della Dott.ssa Lidia Strigari, direttrice dell’unità operativa di Fisica Sanitaria. Il Team ha coinvolto anche l’Unità Operativa di Anatomia Patologica del Policlinico di Sant’Orsola IRCCS (in particolare il dott. Antonio De Leo) e il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie dell’Università di Bologna (referente: Dott.ssa Gloria Ravegnini). Il progetto è stato finanziato dal Ministero della Salute.